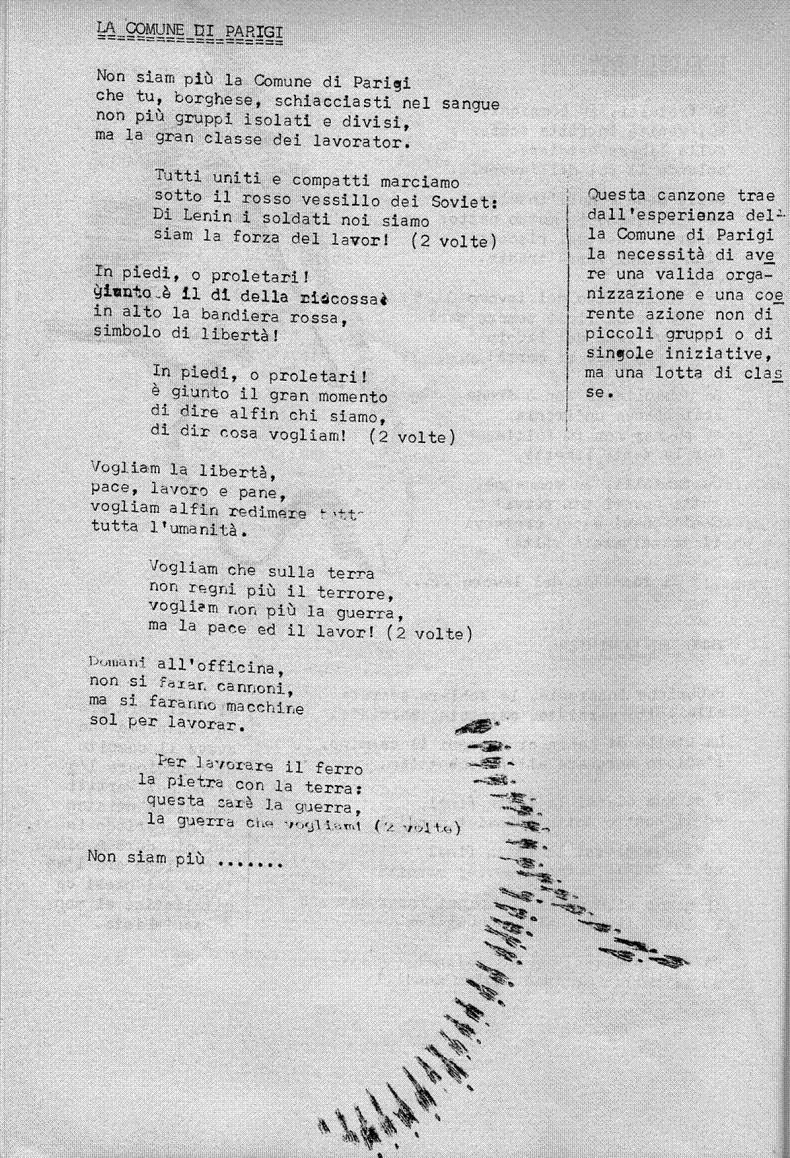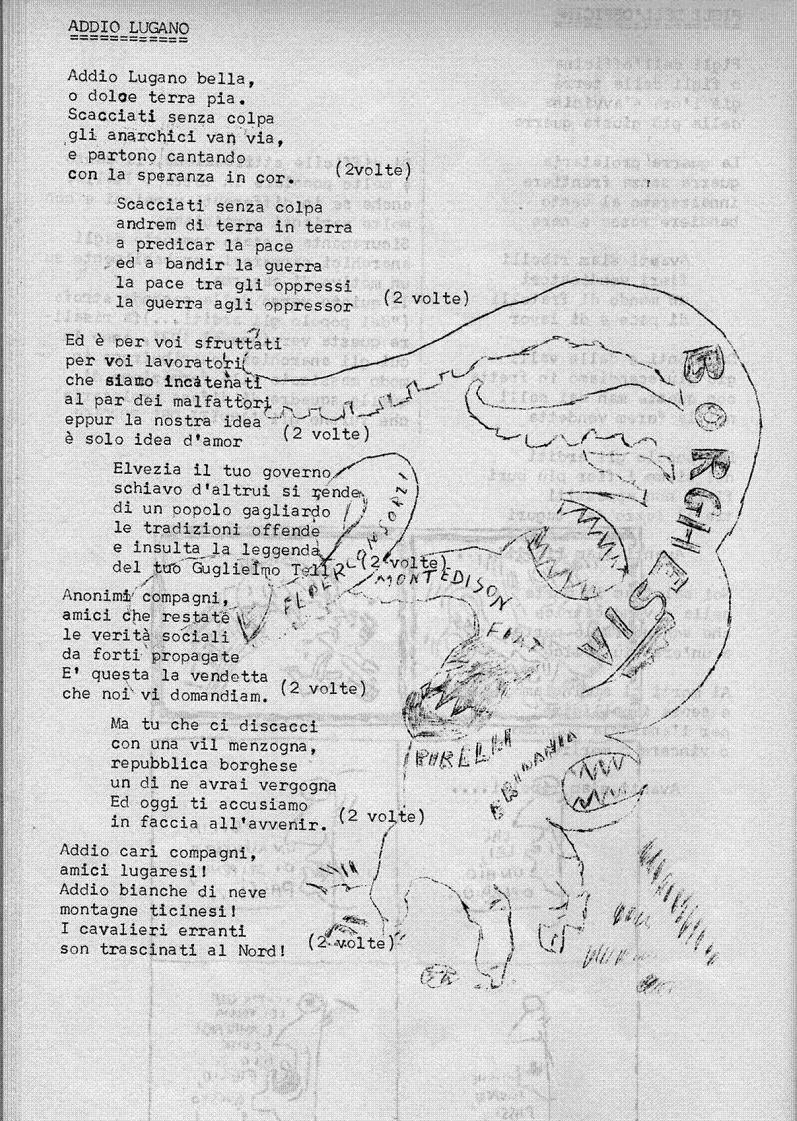Nel libro “La foja de farfaraz” abbiamo naturalmente
riportato la tragedia di Artemio Levi fucilato assieme a Ruffillo. Balzani
anche lui predappiese ed al Forlivese. Antonio Cicognani, ma non con la completezza
di particolari di questa testimonianza del figlio Franco Levi.
Ho incontrato Franco Levi a Rossetta una frazione di
Bagnacavallo dove fu fucilato il padre ad una commemorazione della sez. locale
dell’ANPI, lo conoscevo di vista e di fama essendo stato negli anni ’80 sindaco
di Predappio, ed è stato un piacere. Al ritorno mi ha chiesto di seguirmi con l’auto
perché aveva qualche difficoltà di orientamento dal momento che era calata una
fitta nebbia e lui non conosceva quelle località. Mi ha seguito, ma non l’avesse
mai fatto, ho sbagliato strada, mi sono perso e per tornare a Forlì
praticamente abbiamo girato per tutti i paesi della “bassa”. Mi son detto per
un po’ sarà meglio che non mi faccia vedere da lui, invece Franco si è fatto
vivo e mi ha spedito questa testimonianza e ben 90 foto di suo padre e della
suaf amiglia. Qualcuna si riporta a margine di questo scritto
70° della Liberazione
TESTIMONIANZA: di Franco Levi del padre Artemio
martire della lotta di Liberazione
Artemio levi militare del genio in Jugoslavia
Il mio nome è Franco Levi, figlio di Artemio,
trucidato all'età di soli 28 anni, il 27 Agosto 1944, da un gruppo di fascisti
nella località Rossetta nella provincia di Ravenna.
Allora io avevo cinque anni.
Mio padre, di origine bolognese (nato a Zola Predosa),
arrivò a Predappio come carpentiere con la ditta incaricata della costruzione
dello stabilimento Caproni.
Qui conobbe mia madre, Matilde Petrucci, che sposò, e
con lei vi si stabilì definitivamente.
Amava il suo lavoro, definendolo il più bello al
mondo, perché creativo e vivibile all'aperto. Di lui non conosco il grado di
scolarizzazione, ma mio nonno mi raccontava che frequentò, compatibilmente con
i suoi impegni di lavoro, corsi di disegno tecnico e di tecnologia di
costruzione edilizia. Mia madre mi raccontava che leggeva molto e disegnava di
frequente a matita. Ritraeva: paesaggi, animali, capitelli, monumenti, oltre a disegni
tecnici. Di questa sua passione ci ha lasciato una copiosa testimonianza di:
libri gialli, o sulla storia di vari palazzi storici italiani e tanti disegni a
matita.
I suoi amici, di lui, mi dicevano che mal sopportava
le idee fasciste e le politiche espansionistiche a danno di altri popoli
europei e che soprattutto odiava la guerra; esprimeva apertamente le sue
opinioni, anche se contrarie ai dettami del regime, incutendo talvolta negli
amici il timore di possibili ritorsioni e punizioni.
In occasione di una commemorazione tenutasi anni dopo
la fine della guerra, in onore di mio padre, alcuni suoi ex colleghi di lavoro
e dello stesso ing. Castelli, titolare dell’omonima società, ricordarono il
coraggio mostrato quando unitamente ad altri valorosi, alcuni dei quali forse
partigiani, nascosero dalla predazione tedesca diversi macchinari ed
attrezzature, che poi si rivelarono indispensabili per la ripresa
economico-lavorativa della zona nel primo dopoguerra.
Nonostante le sue idee antifasciste ed antimilitari,
mio padre, chiamato alle armi, adempì il suo obbligo nell’esercito come
sergente del corpo “Genieri” e combatté in Jugoslavia, dove fu fatto
prigioniero. Una volta liberato, tornò a casa grazie ad una licenza premio
nell’Agosto del 1943.
Questo è il periodo in cui il ricordo di mio padre è
più vivido e caro: lo rivedo con matita e squadretta disegnare la casa che
avrebbe voluto costruire per la propria famiglia, una volta terminata la
guerra. Sento la sua voce, mentre mi ritrae su un cartoncino, che mi sussurra:
“Ti disegno con i tuoi capelli ricci e non con il tirabaci che ti fa sempre
la mamma”.
Tutti in famiglia erano convinti che la guerra fosse
finita. Per tal ragione regnava un clima di calma quasi serafica: visi
rilassati, un parlare in maniera sommessa calma e garbata, sia in casa
che con gli amici del vicinato. Ricordo i rumori e le voci di casa mia come se
fossero ovattati: mia madre che chiedeva a mio padre di alzare la voce della
radio per meglio sentire Carlo Butti che in quel momento cantava; mio nonno
materno che, colmo di felicità per aver trovato della farina di mais, proponeva
di fare la polenta a patto che fosse lui stesso a cuocerla. Rivedo mio padre
rilassato a leggere e prendere appunti o a schizzare disegni su ogni foglio di
carta che trovava.
A quella calma apparente, purtroppo, fanno seguito dei
tempi più tesi. Ricordo il momento del sequestro del fucile da caccia a mio
padre e le lagnanze di alcuni cacciatori amici, che a lui si erano rivolti per
avere un consiglio, e l’esporre delle loro ragioni che dissentendo da quanto
stava accadendo dicendo che la moglie e la “s-ciopa” non si presta e non si da
via.
Ricordo le paure di mia madre e di alcune sue amiche
che temevano il richiamo alle armi con la R.S.I. o all’internamento in Germania
dei loro uomini.
A causa di quel clima rivedo la scena di quando, dopo
aver visto dei militi di ronda nel paese, nascosi mio padre sotto una giacca in
un angolo della camera da letto fra il muro e l’armadio perché, a mio dire,
arrivavano i tedeschi per portarlo via. Mi è ancora vivo nella mente il viso
sorridente e lo stretto abbraccio di compiacimento che mi fece per il mio
istintivo gesto d’amore nei suoi confronti.
Mio nonno paterno mi raccontava che mio padre mal
sopportava quel non far niente e quell’isolamento casalingo predappiese,
pertanto era sempre in cerca di lavoro e spesso soggiornava a Imola o a Bologna
e quando poteva tornava a Predappio Alta.
Nell’agosto del 1944, a Predappio mentre si trovava ad
un chilometro dalla vigna di mio nonno, venne prelevato dalle milizie fasciste
del luogo, che operavano in modo casuale dei rastrellamenti in zona, e tradotto
immediatamente nelle carceri di Forlì. Mia madre dopo giorni di ricerca,
rintracciata la prigione, riuscì ad ottenere un colloquio con i capi della
milizia ai quali spiegò il motivo che suo marito si trovava nei pressi del
podere “Porcia” e che nulla era successo in quel luogo che ne giustificasse
l’arresto e ne chiedeva pertanto il rilascio. L’unica cosa che ottenne fu
quella di poterlo rivedere e parlargli.
Triste è il ricordo di quel momento, rivedo un piccolo
atrio con una mitraglia a terra appoggiata su un treppiede con un milite
tedesco in divisa, e uno vestito di scuro che aprì la porta della cella dalla
quale uscì mio padre. Alla mia vista si inginocchiò e aprì le braccia, gli
corsi incontro per abbracciarlo, quando improvvisamente mi sentii strattonare
per il beverino della camiciola e con un piede nel sedere mi ritrovai contro il
muro. Risento l’urlo di mia madre e del tedesco che disapprovando quell’atto
insensato, con garbo mi guidò fra le braccia di mio padre.
Di quell’incontro ricordo che mio padre aveva la
camicia sporca e, dolorante, faticava a mantenere la posizione china che aveva
assunto per abbracciarmi. Io, a mia volta, lo abbracciai fortissimo e quella fu
l’ultima volta che lo vidi.
Anni dopo, già ragazzo, ebbi l’occasione di parlare
con alcuni compagni di cella di mio padre che mi raccontarono delle brutali
torture inflittegli in quei giorni di prigionia e dello stato semi comatoso in
cui gli aguzzini lo riducevano, con quello che loro chiamavano interrogatorio.
Compresi allora le ragioni della sofferenza trapelata durante l’ultimo
abbraccio in carcere.
Egli visse i giorni di prigionia presso il Palazzo che
oggi è la sede della Casa di Cura Villa Igea di Forlì o forse nell’ex
Brefotrofio di Viale Salinature di Forlì, insieme ad un prete e ad un frate, di
cui non ricordo i nomi, ed altresì con Mario Casaglia, fratello dell’Avvocato
Oreste Casaglia anch’egli detenuto in quel periodo. Quest’ultimo, Mario, vegliò
e confortò mio padre la notte prima della sua esecuzione.
La testimonianza riportatami dal sig. Mario Farina,
testimone oculare, che assistette alla raccapricciante esecuzione capitale
eseguita presso Rossetta, mi ha indignato: mi ha sconvolto apprendere che gli
aguzzini ed assassini di mio padre non erano di nazionalità tedesca, come avevo
sempre creduto, ma forlivesi, esseri senza religione e patria mercenari al
servizio della violenza nazista, che evidentemente avevano come loro credo la
sola prevaricazione sugli altri esseri umani.
Nella mattinata del 27 agosto mio padre con altri due
prigionieri vengono portati via da Forlì verso Ravenna dalle brigate nere con
un camioncino. Passano da Bagnacavallo ed arrivano alla Rossetta, un paesino di
campagna lungo un fiume, ad un certo punto svoltano a destra in un cortile e si
fermano sotto la cascina di una casa. Scendono scortati dai fascisti,
attraversano la strada ed entrano nel cortile delle scuole, un edificio
massiccio con grandi finestre. Arrivati sul retro c’è un gruppetto di tedeschi
con le mitragliatrici appostati in una buca. Poco lontano sulla destra c’è
un’altra buca non tanto grande ma più profonda. Gli stessi fascisti che li avevano
trasportati da Forlì a Rossetta furono anche gli autori dell’efferato eccidio.
I brigatisti, armi in pugno, si posero davanti alla fossa nella quale uno alla
volta fecero scendere i prigionieri: Il primo fu Balzani, il più anziano, era
distrutto e a stento si reggeva in piedi. Poi toccò a Cicognani, partigiano
della 29a Brigata Garibaldi, che morì con una seconda raffica.
Infine fu il momento di Artemio Levi, dei tre era il più giovane aveva appena
compiuti 28 anni, era forte e non aveva paura. Ha visto morire i suoi compagni
e sebbene inorridito da tale crudeltà rimase imperterrito. Lui non scende nella
fossa e, anche se ha le mani legate dietro la schiena, va incontro ai suoi
carnefici per colpirli con parole di biasimo e disprezzo. E così che da uomo
impavido volò via sopra quegli spari, cadendo sopra ai suoi compagni.
Mi ha commosso e inorgoglito sapere come mio padre,
prima che gli sparassero in faccia e a breve distanza, abbia guardato in viso i
suoi carnefici ed abbia rivolto loro parole sprezzanti e di ribellione di
fronte a quella disumanità. Pur non conoscendo esattamente le parole
pronunciate prima di cadere sotto i colpi d’arma da fuoco, sono certo che abbia
gridato loro:“Io sono un italiano, voi chi siete?! Qual’è la vostra Patria?!
Per chi e per cosa fate tutto ciò?!”.
Franco Levi
Artemio Levi militare in Jugoslavia